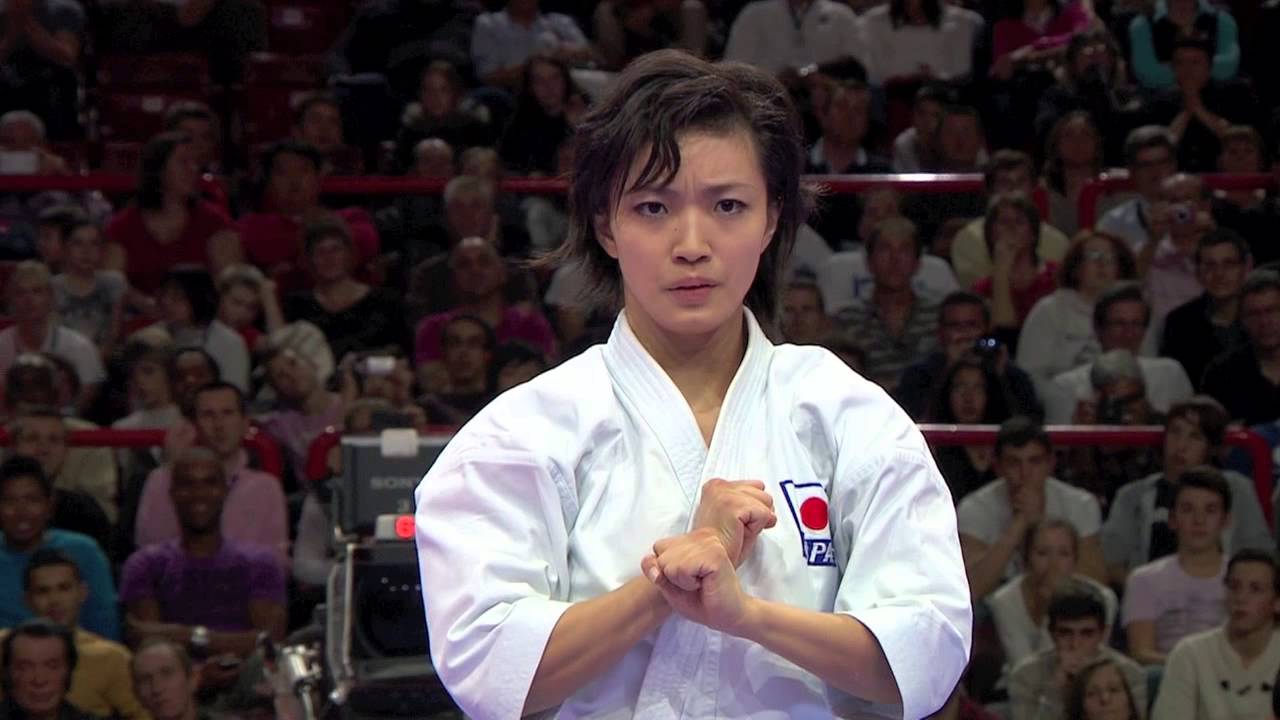1. Krav Maga (Voto: 9.5/10)
Partiamo
dal primo, e non a caso. Il Krav Maga è stato sviluppato per una
ragione specifica: insegnare a ragazzi ebrei mingherlini a
sopravvivere ai pogrom negli anni '30 . Non c'è filosofia, non
c'è estetica, non c'è competizione. C'è solo: "Come faccio a
neutralizzare questa minaccia e tornare a casa vivo?".
Perché funziona: colpi agli occhi, alla gola, all'inguine; disarmi immediati; difesa da più aggressori; uso di oggetti di fortuna .
Il limite: molti corsi commerciali sono annacquati. Devi trovare un istruttore vero, possibilmente con esperienza militare o nelle forze dell'ordine.

2. Muay Thai (Voto: 9/10)
L'"arte degli otto arti" non è una frase fatta. Gomiti, ginocchia, pugni, calci: tutto è progettato per fare male davvero . I thailandesi si allenano a prendere colpi, a incassare, a non indietreggiare. E in strada, chi non arretra vince.
Perché funziona: devastante a media e corta distanza. Le clinchate ti permettono di controllare l'avversario mentre lo distruggi con le ginocchia .
Il limite: Poca enfasi sulla lotta a terra. Se vai giù, sei in difficoltà.

3.
Boxe (Voto: 8.5/10)
Sembra
semplice, ma non lo è. La boxe ti insegna tre cose fondamentali:
colpire, schivare, muoverti . In strada, la maggior parte degli
scontri finisce in pochi secondi con un cazzotto ben piazzato. Il
pugile sa mettere tutto il peso in quel cazzotto .
Perché funziona: gioco di gambe, lettura delle distanze, incassare i colpi. E il pugno è l'arma più naturale che abbiamo.
Il limite: solo pugni, niente calci, niente lotta. E i guantoni non ci sono, quindi le mani si rompono.

4.
Judo (Voto: 8.5/10, ex aequo con la Boxe)
Il
judo vecchia scuola, quello che insegnava a usare il marciapiede come
alleato, è forse la cosa più sottovalutata in ottica autodifesa.
Una proiezione ben eseguita su asfalto finisce la lotta in un
istante .
Perché funziona: sbilanciamento, proiezioni, controllo a terra. Un judoka ti fa cadere e non ti lascia rialzare .
Il limite: richiede anni per padroneggiare le proiezioni in condizioni di stress. E in piedi, contro uno che tira pugni, devi chiudere la distanza senza prendere botte.

5.
Brazilian Jiu-Jitsu (Voto: 8.5/10, ex aequo)
Lo
so, lo so: il BJJ è fantastico. Ma in strada ha un problema gigante:
ti porta a terra, e a terra sei vulnerabile a calci, coltelli e amici
dell'aggressore . Detto questo, se lo combini con qualcos'altro,
è letale.
Perché funziona: il controllo a terra è insuperabile. Se sai portare lì l'avversario e hai amici che ti coprono, vinci .
Il limite: la posizione supina è la peggiore in una rissa di strada. E molti praticanti sono abituati a combattere seduti, non a entrare in contatto sotto i colpi.

6.
Wing Chun (Voto: 7/10)
Il
Wing Chun è stato sviluppato per le strade affollate e criminali di
Hong Kong . In teoria, è perfetto per distanza ravvicinata. In
pratica, molti praticanti moderni non fanno sparring vero e non sanno
cosa significa prendere un pugno in faccia .
Perché funziona: scoppio di potenza a corta distanza, mani appiccicose, economia di movimento .
Il limite: se non fai sparring duro, se non testi le tue tecniche contro qualcuno che resiste, è solo una danza.
7. Kyokushin Karate (Voto: 7/10, con una precisazione importante)
E arriviamo al punto. Il Kyokushin merita un discorso a parte.
Fondato da Masutatsu Oyama, il Kyokushin è uno degli stili di karate più duri in assoluto . I combattimenti sono a pieno contatto, senza protezioni, e si può colpire con tutto tranne che con i pugni al viso . Questo crea guerrieri con una resistenza fisica e mentale fuori dal comune.
Il fondatore, Oyama, era un tipo tosto. Si racconta che abbia ucciso un toro a mani nude (anche se con un colpo alla testa, non proprio una scena da western). E ha creato una prova, l'Hyakunin Kumite, dove il combattente deve affrontare 100 avversari uno dopo l'altro . Roba da pazzi.
I punti di forza del Kyokushin sono evidenti:
Condizionamento fisico bestiale: i praticanti si abituano a prendere colpi, a incassare, a non mollare .
Calci devastanti: bassi, alti, circolari. Le gambe sono armi .
Filosofia del "non arrendersi mai": lo spirito forgiato nella sofferenza è un'arma in sé .
Ma c'è un limite enorme, e lo riconoscono anche i praticanti onesti: nel Kyokushin tradizionale, non si colpisce il viso con i pugni . Questo crea una "cecità" pericolosissima in strada. Uno abituato a combattere senza paura di prendere pugni in faccia, quando si trova davanti uno che gliene tira uno, può andare in tilt.
Il verdetto sul Kyokushin: se lo integri con un po' di boxe per colmare il vuoto della guardia al volto, diventa un'arte completa e temibile. Da solo, rischi di incassare un destro che non hai mai imparato a parare . Voto 7, ma con la consapevolezza che è un 7 con le palle.

8.
Taekwondo (Voto: 6/10)
Calci
spettacolari, velocità, flessibilità . Peccato che in strada,
un calcio alto sia il modo più veloce per finire a terra con una
gamba in mano a qualcuno.
Perché funziona: se hai una distanza e puoi colpire basso, può funzionare.
Il limite: troppo acrobatico, troppo poco concreto. Le versioni sportive hanno ucciso l'efficacia originaria .

9.
Aikido (Voto: 5/10)
Lo
dico con rispetto: l'Aikido è bellissimo, è filosofia pura, è
armonia. Ma in strada, contro uno che ti viene addosso ubriaco e
incazzato, le leve e le proiezioni "morbide" spesso non
funzionano . Richiedono una collaborazione che l'avversario non
ti darà mai.
Perché funziona: in teoria, se sei un maestro con 30 anni di esperienza.
Il limite: nella pratica, contro uno non collaborativo, è un suicidio.

10.
Kung Fu Tradizionale (Voto: 4/10)
Attenzione:
parlo del Kung Fu "da parco", quello con le forme lunghe e
i movimenti acrobatici. Il Sanshou (versione da combattimento) è
un'altra cosa . Ma il Kung Fu tradizionale, quello che si vede
nei film, è spesso una coreografia. E le coreografie, in strada, ti
fanno ammazzare.
Come dicevamo all'inizio, nessuna arte marziale ti salva se sei un coglione. La strada è un'altra cosa. È merda, è paura, è sangue. È il tipo che non si ferma quando cadi, che ti tira un calcio in testa mentre sei già a terra, che tira fuori un coltello quando perde.
Le arti marziali sono strumenti. Il miglior martello del mondo non costruisce una casa da solo. Serve l'uomo che lo impugna. E quell'uomo deve avere il ferro dentro. Deve essere disposto a soffrire, a incassare, a rialzarsi. Deve avere una tendenza al lato oscuro. Perché in strada, chi è troppo buono, troppo educato, troppo "marziale", perde.
Il Kyokushin, in questo senso, è una fucina di uomini duri. Ti tempra, ti forgia, ti insegna a non mollare. Ma se non colmi il buco della guardia al viso, rischi di finire K.O. per un pugno che non hai mai imparato a parare.
Il Kyokushin è nella lista, eccome. Ma è un gradino sotto i primi. Perché in strada, la "verità suprema" è una sola: sopravvivere. E per sopravvivere, devi essere pronto a tutto. Anche a prendere un pugno in faccia.