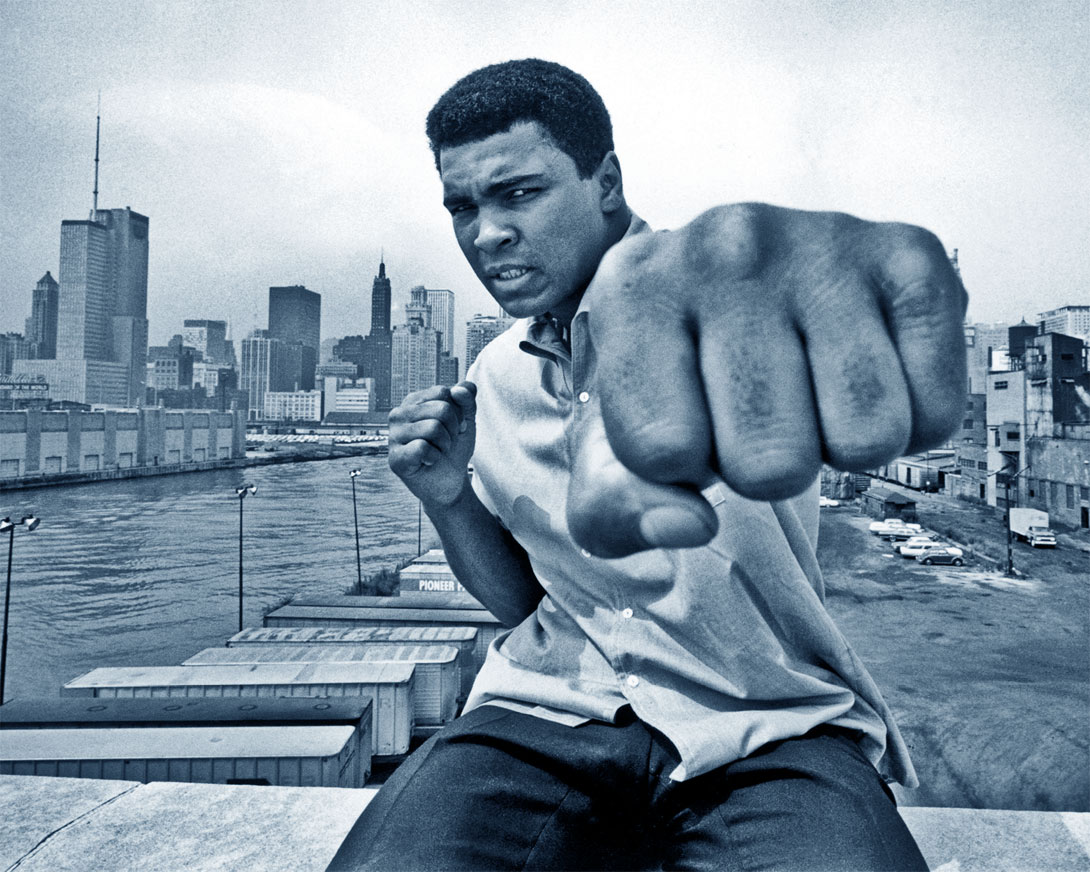Nel mondo delle arti marziali, poche domande dividono tanto quanto questa: è possibile creare un proprio stile di kenjutsu o di scherma? È un interrogativo che affascina praticanti, istruttori e studiosi da secoli, perché tocca il cuore stesso del rapporto tra tradizione e innovazione. Da un lato, c’è la fedeltà alle scuole antiche, ai maestri e ai principi che hanno attraversato i secoli; dall’altro, c’è la naturale spinta dell’essere umano a esplorare, contaminare, reinterpretare.
Creare un proprio stile non significa inventare qualcosa di completamente nuovo, ma interiorizzare ciò che si è appreso e poi lasciare che, attraverso l’esperienza, emerga un modo personale di combattere. È un processo organico, quasi naturale.
1. Il punto di partenza: imparare la lingua della spada
Ogni arte, prima di essere trasformata, va compresa. Nessuno scrive poesia senza conoscere la grammatica, e nessuno crea un proprio stile di scherma senza aver prima imparato la lingua del combattimento.
Nel kenjutsu, come nella scherma occidentale, esistono strutture precise: guardie, traiettorie, tempi, principi di distanza e linee d’attacco. Questi elementi costituiscono la “grammatica” della spada. Solo dopo averli padroneggiati si può iniziare a parlare con accento proprio.
Una lama risponde alle stesse logiche fondamentali: equilibrio, leva, peso, centro di gravità, velocità. Ciò che cambia non è la funzione dell’arma, ma il modo in cui l’uomo la interpreta.
2. Le scuole come fondamenta, non come gabbie
Ogni scuola di scherma — giapponese o occidentale — è un linguaggio. Le ryūha del Giappone feudale, così come i sistemi di Fiore dei Liberi, Liechtenauer o Roworth in Europa, rappresentano sintesi di esperienze e filosofie. Nessun maestro è mai partito da zero: ognuno ha reinterpretato ciò che lo precedeva, aggiungendo un tassello personale.
Creare un proprio stile, dunque, non significa rigettare la
tradizione, ma diventare tradizione vivente.
Il
problema nasce quando si confonde la libertà con la mancanza di
struttura.
Chi “inventa” uno stile prima di avere basi solide
non sta creando: sta solo improvvisando.
Il maestro, invece, crea
attraverso la padronanza.
Nel kenjutsu, la differenza tra un innovatore e un eretico è sottile ma cruciale: il primo conosce le regole e le piega con consapevolezza; il secondo le ignora e le sostituisce con arbitrarietà.
3. Assimilazione e contaminazione
Dopo anni di pratica in un sistema, è naturale sviluppare un modo
di combattere che non appartiene esclusivamente a quella scuola, ma
la contiene e la arricchisce con esperienze parallele.
Ogni
praticante esperto finisce per sviluppare un “dialetto marziale”,
una serie di scelte, preferenze e riflessi che lo distinguono dagli
altri, pur restando all’interno dello stesso sistema.
Questo vale anche nel kenjutsu: il kendōka che ha
studiato iai svilupperà un approccio più fluido; il
praticante di katori shintō ryū che ha esperienza di
jūjutsu interpreterà i movimenti in modo più circolare e
meno lineare.
Lo stile personale è il risultato di esperienze
incrociate, non di teorie astratte.
4. Il valore della contaminazione: quando le tradizioni si incontrano
È importante comprendere come influenze di scuole diverse possano essere integrate senza perdere coerenza. Tecniche e principi di sistemi differenti possono rafforzare la comprensione complessiva del combattimento.
Anche nel Giappone feudale, i samurai più esperti studiavano più
scuole contemporaneamente, fondendo kenjutsu, iai e
jūjutsu per ottenere una comprensione più profonda del
combattimento.
Non è un caso che molte scuole antiche siano nate
proprio da queste sintesi.
La Tenshin Shōden Katori Shintō
Ryū, ad esempio, influenzò decine di altre tradizioni, ognuna
delle quali reinterpretò i suoi principi adattandoli alle proprie
esigenze.
In Europa accadde lo stesso: dal Rinascimento all’Ottocento, la
scherma fu un continuo dialogo tra culture, tecniche e filosofie. Gli
italiani influenzarono i francesi, i francesi gli inglesi, gli
inglesi gli ungheresi, e così via.
Il risultato non fu la perdita
dell’identità, ma la nascita di una lingua universale
della lama.
5. Personalità marziale: il temperamento come stile
Ogni spadaccino sviluppa nel tempo una propria “personalità
marziale”.
C’è chi ama la distanza lunga e il gioco di filo,
chi preferisce il bind e il corpo a corpo, chi cerca il colpo
risolutivo, chi lavora di logoramento.
Queste scelte non sono
casuali, ma rispecchiano la natura dell’individuo:
la sua fisicità, la sua mente, il suo modo di percepire il rischio.
Lo stile personale non è una regola codificata, ma una risposta
spontanea e coerente alla realtà del combattimento.
Quando
il corpo si muove secondo la propria logica, non più per imitazione
ma per convinzione, nasce l’autenticità.
6. Il potere dei limiti: la forma nasce dalla restrizione
Un concetto fondamentale: la libertà nasce dal
limite.
Allenarsi con restrizioni — regole specifiche,
distanze ridotte, mani legate, armi non affilate — costringe il
cervello a trovare nuove soluzioni.
È proprio questa disciplina
imposta che permette alla creatività di emergere in modo
strutturato.
I samurai lo chiamavano shugyō: la pratica ascetica
volta a cercare l’essenza attraverso la ripetizione e la
privazione.
Il principio è identico in tutte le culture: solo
attraversando il rigore si può arrivare alla fluidità.
Il maestro moderno che vuole sviluppare un proprio stile deve dunque allenarsi in molte condizioni, osservare cosa rimane efficace in ogni scenario e lasciare che la funzionalità guidi l’estetica.
7. Quando un “modo di combattere” diventa uno stile
Lo stile personale non nasce da un manifesto o da un nome.
Nasce
quando la tecnica smette di appartenere al maestro e diventa una
naturale estensione di sé stessi.
Il vero stile è quello che
emerge quando guardia, tempo e colpo raccontano chi sei, senza
parole.
Chi ha uno stile personale non sente il bisogno di proclamare la
propria “scuola”.
È la padronanza naturale e coerente del
movimento che rende unico ogni praticante.
8. Tradizione e identità: il filo invisibile
Nel kenjutsu e nella scherma storica, il dilemma tra fedeltà e
innovazione non ha mai avuto una risposta definitiva.
La verità è
che entrambe le forze devono coesistere.
Senza
tradizione, lo stile personale diventa improvvisazione.
Senza
individualità, la tradizione si irrigidisce e muore.
Ogni spadaccino, a un certo punto, si trova davanti a una scelta:
ripetere o interpretare.
Ma la via più alta è quella che unisce
le due dimensioni — la tradizione come radice,
l’individualità come fiore.
Creare il proprio stile non significa fondare una nuova scuola, ma
trovare la propria voce all’interno di una lingua
antica.
Ogni colpo, ogni passo, ogni parata è una
parola; ogni duello, un dialogo tra due grammatiche che si
incontrano.
Alla fine, ciò che conta davvero non è se il tuo stile ha un
nome, ma se la tua lama parla con sincerità.
Perché, come
scriveva un antico maestro giapponese:
“Quando la spada è pura, essa taglia il cielo e la mente nello stesso istante.”
In quel momento, non esistono più scuole, etichette o
sistemi.
Esisti solo tu, la tua arma e il flusso del movimento —
la tua verità.